Ho fatto un massaggio una volta. In realtà, più di una. Un massaggio particolare, spirituale. Mi han visto una vita precedente. Non avevo mai riflettuto sulla reincarnazione, e ammetto, mi attrae, è affascinate. Mi piace pensare che le anime restino. Ci penso oggi, più che mai, nell’anniversario di morte del celeberrimo “Faber”, l’affascinante cantautore genovese.
Mi innamorai di Fabrizio De Andrè che ero molto piccola, ancora oggi i suoi testi risuonano nella mia mente con la voce in sottofondo di mia madre che cantava Marinella per farmi addormentare. Il suo primo disco fu inciso nel 1967, mia madre penso collezionasse tutte le sue audiocassette, all’ora anche lei era bambina e come me è cresciuta con le sue poesie. Generazioni che si susseguono e mi emoziono. Penso soprattutto a quanto Fabrizio De Andrè ha dato alla musica italiana. Non si può immaginare un gruppo di amici intorno ad un fuoco, una chitarra, senza ascoltare le anime di Bocca di Rosa, il Pescatore, Geordie, che danzano e raccontano le proprie storie. Storie e personaggi che rimangono intatti al mutare del tempo e dello spazio.
Il cantautore nasce nel ’40 e vive la propria infanzia nella Genova del dopoguerra, non a caso il tema bellico verrà ripreso sotto vari aspetti in alcune dell sue canzoni. Studia, si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza, ma a sei esami dalla laurea lascia gli studi per dedicarsi alla musica. Menomale, aggiungo io. De Andrè è sempre stato diverso, viveva fuori dagli schemi, conduceva una vita sregolata. Ebbe problemi di dipendenza e abuso d’alcool, la donna che frequentava all’epoca era una prostituta, Anna. Sbarcava il lunario con svariati lavoretti; Paolo Villaggio, suo amico, lo inserì addirittura come musicista su alcune navi da crociera.
La sua sregolatezza, però, non gli impediva di guardarsi intorno, di studiare, interpretare, interrogarsi e vivere la società a cui apparteneva, era evasione dalla stessa. Si definì un anarco-individualista, era ribelle. Tutti lo ricordano come “il poeta degli sconfitti”, era portavoce di quei soggetti che vivevano ai margini della società. Non c’era paura, pregiudizio, non trapelava arroganza dai suoi lineamenti segnati dal tempo, quando lo vedevi lì, seduto, accarezzare le corde della sua chitarra e intonare le sue canzoni.
Via del Campo, una sfilata di prostitute, travestiti, gente povera, emblema del vicolo genovese più malfamato. Gli ultimi versi ci ricordano che è dal letame che nascono i fior. De Andrè toccava corde delicate, temi complessi e attuali. Geordie rubava i cervi del re, ma lo faceva per fame; Piero combatteva al fronte, ma non sapeva uccidere. Si opponeva, fortemente, a quelle maggioranze, quei luoghi comuni, che schiacciano, opprimono e spingono all’emarginazione, al razzismo, all’indifferenza della società. Il suicidio è stato un altro dei temi affrontati: in Preghiera in Gennaio, che scrisse alla morte dell’amico Luigi Tenco, come anche ne La Ballata del Michè, De Andrè implora pietà, la pietà della Chiesa che, paradosso, ripudia i suicidi.
Esaltò l’importanza dei dialetti, soprattutto quello ligure e dedicandosi in maniera minore a quello gallurese e, ovviamente non poteva mancare, il napoletano. In Don Raffaè ci parla della camorra, che se da un lato è un male, dall’altro è bene, è lavoro, speranza. Dove ci sono lacune da parte dello Stato interviene la criminalità organizzata che mette le toppe. Senza peli sulla lingua asserì in un’intervista che senza queste organizzazioni la disoccupazione sarebbe aumentata vertiginosamente.
Morì a Milano De Andrè, l’11 gennaio del 1999. Ma quel che ha lasciato ben 17 anni fa non è cambiato molto. Tutti quei temi tabu’ ritornano. E a noi non resta che lasciarci cullare dalle sue note.
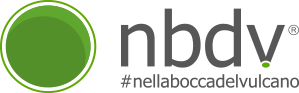









Nessun Commento